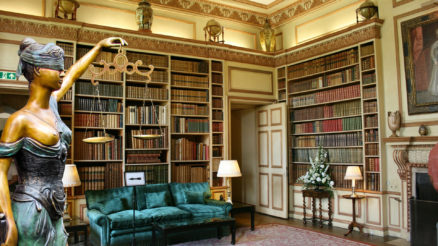Questo articolo è valutato
( votes)Premesse
Con delibera n. 1309 del 28 dicembre scorso, l’ANAC ha approvato le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 («Linee Guida»), il cui schema preliminare era stato previamente sottoposto ad apposita consultazione aperta agli operatori interessati dall’11 novembre al 28 novembre 2016 scorso. Le Linee Guida rientrano nell’ambito della attività svolta dalla Autorità in materia di trasparenza, affiancando la delibera n. 1310, approvata nella medesima seduta, relativa alla attuazione degli obblighi di pubblicità̀, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013.
Le Linee Guida definiscono il regime delle esclusioni e dei limiti all’accesso come introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016 che ha, sul punto, integrato gli artt. 5 e 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013 (recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità̀, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», cd. «Decreto trasparenza»). L’istituto in parola rappresenta una nuova tipologia di accesso (di seguito «accesso generalizzato») concernente dati, documenti e informazioni, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali la legge impone un obbligo di pubblicazione.
L’ANAC intende quindi porre le basi per la concreta attuazione della riforma delineata nel D.Lgs. 33/2013, volta non solo a favorire forme di controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche – e soprattutto – a garantire la tutela dei diritti dei cittadini e la promozione della partecipazione degli interessati all’attività̀ amministrativa. La libertà di accedere a tali dati dovrebbe quindi divenire centrale nel nuovo sistema, analogamente a quanto avviene negli ordinamenti caratterizzati dal Freedom of Information Act (FOIA).
1. Peculiarità del nuovo istituto
La nuova tipologia di accesso è stata introdotta dal D.Lgs. n. 97/2016, che ha a tal fine modificato l’art. 5, comma 2, affiancando all’esistente accesso civico una nuova figura di accesso, che consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, che siano ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto trasparenza, salvo il rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.
Il diritto di accesso generalizzato si configura come diritto a titolarità diffusa in quanto suscettibile di essere azionato «da chiunque e non soggetto ad alcuna limitazione dipendente dalla eventuale legittimazione soggettiva del richiedente. Ciò è in linea con l’ordinamento dell’Unione Europea (il Trattato e la Carta dei diritti fondamentali) in cui il diritto di accesso non è preordinato alla tutela di una propria posizione giuridica soggettiva e, quindi, non richiede la prova di un interesse specifico.
L’«accesso generalizzato» previsto dal D.Lgs. n. 97/2016 consente a chiunque, anche in assenza di apposita motivazione, di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Corollario di tale novità è la possibilità di esercitare il diritto in questione senza necessità di motivare le ragioni a fondamento della richiesta di accesso.
L’istituto va quindi distinto dall’«accesso documentale» disciplinato dal capo V della L. 241/1990 e dall’«accesso civico» già disciplinato dall’art. 5, comma 1, dello stesso Decreto trasparenza, che riguarda, al contrario, i documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione.
In particolare, l’accesso civico, che, come l’accesso generalizzato, è azionabile da chiunque vi abbia interesse, resta utilizzabile quale rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, presupponendo quindi l’esistenza di oneri di pubblicazione imposti dal D.Lgs. 33/2013: quest’ultimo impone, infatti, la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche contenute nel relativo allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni.
L’accesso previsto dalla L. 241/90 («accesso documentale») è anch’esso distinto dall’accesso generalizzato, in quanto è volto a consentire l’accesso ai documenti della pubblica amministrazione a determinati soggetti (titolari di specifiche posizioni giuridiche qualificate) previa dimostrazione dell’esistenza in capo al richiedente di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso». Il limite di questa forma tradizionale di accesso, inoltre, è proprio quel controllo generalizzato sulla attività della pubblica amministrazione che, al contrario, il nuovo accesso vuole consentire.
Il sovrapporsi di diversi regimi in tema di accesso induce l’ANAC, nelle recenti Linee Guida, a suggerire ai soggetti tenuti all’applicazione del Decreto trasparenza l’adozione, anche nella forma di un regolamento interno sull’accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.
Il suggerimento dell’ANAC implica dunque l’individuazione degli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato e di la disciplina della procedura per la valutazione, caso per caso, delle richieste di accesso.
2. Differenze rispetto all’«accesso documentale» di cui alla L. 241/90
Nelle Linee Guida in esame l’ANAC si è occupata di disciplinare i rapporti tra il nuovo istituto e l’esistente e ben nota fattispecie di accesso agli atti delineata dalla L. 241/90, precisando, in particolare, che:
- vi sono ipotesi in cui è negato l’accesso generalizzato ad atti e documenti ed è invece possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ai medesimi; resta, infatti, ferma la possibilità̀ che, ad esempio, i dati personali per i quali sia stato negato l’accesso generalizzato possano essere resi ostensibili al soggetto che abbia comunque motivato nell’istanza l’esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso», trasformando di fatto, con riferimento alla conoscenza dei dati personali, l’istanza di accesso generalizzato in un’istanza di accesso ai sensi della L. 241/1990;
- vi sono casi in cui, per ragioni di coerenza sistematica e a garanzia di posizioni individuali specificamente riconosciute dall’ordinamento, il diniego di accesso ai sensi della L. 241/1990, se motivato sulla base di esigenze di «riservatezza» pubblica o privata, influisca anche ai fini dell’accesso generalizzato, impedendo quest’ultimo ove la relativa istanza sia identica e presentata nel medesimo contesto temporale della istanza ai sensi della L. 241/1990; in tale ipotesi, si deve ritenere infatti che le stesse esigenze di tutela dell’interesse pubblico o privato sussistano anche in presenza di una richiesta di accesso generalizzato, anche presentata da altri soggetti;
- per ragioni di coerenza sistematica, quando viene concesso un accesso generalizzato non può essere negato, per i medesimi documenti e dati, un accesso ai sensi della L. 241/90.
Le due diverse discipline, inoltre, in parte potrebbero sovrapporsi con riguardo al regime delle esclusioni del diritto di accesso. In particolare, come evidenziato da ANAC, vi potrebbero essere casi in cui l’accesso ad uno stesso documento debba essere tassativamente escluso ai sensi della L. 241/90 mentre potrebbe non essere escluso come accesso generalizzato (rientrando tra le eccezioni relative all’accesso di cui al Decreti trasparenza). Al fine di evitare possibili conflitti, l’ANAC segnala allora la necessità che in tali casi le amministrazioni tengano in adeguata considerazione il grado di maggiore trasparenza al quale deve essere assoggettata l’attività̀ istituzionale a seguito dell’intervento novellatore di cui al D.Lgs. 97/16, valutando caso per caso le istanze di accesso a dati, documenti o informazioni detenute dalle medesime, anche alla luce del principio della successione delle leggi nel tempo e della specialità̀ e ratio della nuova disciplina.
3. Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del nuovo istituto
Sul piano soggettivo, la disciplina sull’accesso generalizzato si applica:
1. alle pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, comma 1, Decreto trasparenza) ossia “tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese le autorità̀ portuali, nonché́ le autorità̀ amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione” (art. 2-bis, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013);
2. “in quanto compatibile” a enti pubblici economici, ordini professionali, società̀ in controllo pubblico[1] e ad altri enti di diritto privato assimilati[2](art. 2- bis, comma 2, Decreto trasparenza);
3. “in quanto compatibile” e “limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività̀ di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”[3] alle società̀ a partecipazione pubblica (di cui al d.lgs. 175/2016[4]) ed altri enti di diritto privato assimilati nonché́ alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità̀ giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività̀ di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici (art. 2-bis, comma 3, Decreto trasparenza).
La dizione usata dal legislatore («in quanto compatibile») poteva far sorgere dubbi circa l’applicabilità del nuovo accesso ai soggetti di cui ai punti 2 e 3 sopra menzionati. L’ANAC ha allora chiarito, con le Linee Guida in oggetto, che l’accesso generalizzato va comunque ritenuto “compatibile” con la natura e le finalità̀ dei soggetti sopra elencati ai punti 2 e 3, considerato che l’attività̀ svolta dagli stessi è diretta alla cura di interessi pubblici e che, pertanto, questo tipo di accesso può essere richiesto anche a tali soggetti.
Sul piano oggettivo, come sopra esposto, l’accesso generalizzato è esercitabile solo quando si voglia accedere a documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni che non siano soggetti a formale obbligo di pubblicazione.
Si tratta pertanto non solo di «documenti amministrativi», ma anche di «dati» indipendentemente dal supporto fisico che li contiene e a prescindere dai vincoli derivanti dalle modalità̀ di organizzazione e conservazione.
Il legislatore in tal modo legittima anche la presentazione di richieste di accesso che si limitino a identificare/indicare i dati desiderati, sebbene prive della indicazione degli estremi di eventuali documenti in cui essi sono contenuti. Al contempo, come evidenziato dall’ANAC, non dovrebbero considerarsi ammissibili richieste meramente esplorative e generiche, volte semplicemente a «scoprire» di quali informazioni l’Amministrazione dispone, essendo invece necessario che l’istanza di accesso consenta l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, quantomeno, alla loro natura e al loro oggetto[5].
La richiesta di accesso generalizzato deve, inoltre, riguardare un numero non manifestamente irragionevole di documenti e dati, legittimando, in caso contrario, il destinatario a ponderare e valutare, da un lato, il concreto interesse del richiedente all’accesso ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, in modo da non compromettere l’interesse al buon andamento dell’Amministrazione.
L’ANAC evidenzia, ancora, che la richiesta di accesso riguarda solo i dati già a disposizione della Amministrazione interpellata, dovendosi escludere che per soddisfare tale richiesta l’Amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già̀ in suo possesso. Pertanto, l’amministrazione non ha l’obbligo di rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato, ma solo di consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già̀ detenute e gestite dall’amministrazione stessa.
Ai sensi della nuova normativa, l’istanza di accesso concerne dati, indipendentemente dal supporto fisico che li contiene e a prescindere dai vincoli derivanti dalle relative modalità̀ di organizzazione e conservazione; al contempo non deve essere esplorativa e/o generica, dovendo consentire l’individuazione del dato con riferimento, almeno, alla natura e all’oggetto.
4. Eccezioni all’accesso
Per quanto generalizzato, l’accesso in esame è temperato dalla previsione di specifiche eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che potrebbero subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni.
L’ANAC disciplina in dettaglio le ipotesi in cui tale diritto deve ritenersi escluso ovvero limitato, distinguendole in «assolute» e «relative»:
A) eccezioni assolute (art. 5bis, comma 3, Decreto trasparenza), aventi carattere tassativo, che ricorrono nei casi di
a1. segreto di Stato[6];
a2. altri divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge (a titolo esemplificativo l’ANAC rammenta il segreto statistico di cui al D.lgs. n. 322/1989; il segreto militare ex RD n. 161/1941; il segreto bancario di cui al D.lgs. n. 385/1993; i limiti alla divulgazione relativi agli archivi del Centro elaborazione dati in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ex L. n. 121/1981; le disposizioni sui contratti secretati previste dall’art. 162 D.lgs. n. 50/2016; il segreto scientifico, il segreto industriale, il segreto istruttorio, il segreto professionale, il segreto sul contenuto della corrispondenza, i “pareri legali” sul diritto di difesa in un procedimento contenzioso previsti dal codice penale; il segreto d’ufficio ex art. 15 del d.P.R. n. 3/1957[7]);
a3. i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche modalità̀ o limiti (a titolo esemplificativo, l’ANAC rammenta la disciplina sugli atti dello stato civile e quella sulle informazioni contenute nelle anagrafi della popolazione conoscibili nelle modalità̀ previste dalle relative discipline di settore, agli Archivi di Stato e altri Archivi disciplinati dagli artt. 122 ss. del D.Lgs. n. 42/2004; agli elenchi dei contribuenti e alle relative dichiarazioni dei redditi la cui visione ed estrazione di copia è ammessa nelle forme stabile dall’art. 69, comma 6, del d.P.R. n. 600/1973), inclusi quelli di cui all’art. 24, comma 1, L. n. 241 del 1990[8];
B) eccezioni relative o qualificate (art. 5bis, commi 1-2, Decreto trasparenza) volte ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici quali: a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività̀ ispettive; ovvero alla tutela di interessi privati quali: a) protezione dei dati personali; b) libertà e segretezza della corrispondenza; c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà̀ intellettuale, diritto d’autore e segreti commerciali. Per ciascuna di queste categorie di interessi pubblici e privati l’ANAC fornisce alcune indicazioni utili alle Amministrazioni nella identificazione concreta dei casi in cui poter negare l’accesso (pag. 15 e ss. Linee Guida).
Le Linee guida ANAC individuano in dettaglio le ipotesi in cui l’accesso generalizzato deve essere escluso (eccezioni assolute) ovvero può essere escluso previa verifica caso per caso dell’amministrazione (eccezioni relative).
Le eccezioni relative al diritto di accesso generalizzato operano solo previa valutazione caso per caso dalla Amministrazione, tale da verificare una volta accertata l’assenza di eccezioni assolute, se l’ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore. Il diniego dell’accesso in tali ipotesi non opera automaticamente ma va disposto a seguito di apposita valutazione accompagnata e sorretta da idonea motivazione. Come chiarito dall’ANAC, l’Amministrazione non può̀ in tali casi limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, ma dovrà̀ valutare il pregiudizio rispetto al momento ed al contesto in cui l’informazione viene resa accessibile, e non in termini assoluti ed atemporali, in modo da:
- indicare chiaramente quale – tra gli interessi elencati all’art. 5 bis, co. 1 e 2 – viene pregiudicato;
- valutare se il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende direttamente dalla disclosure dell’informazione richiesta;
- valutare se il pregiudizio conseguente alla disclosure è un evento altamente probabile, e non soltanto possibile.
Al fine di limitare la discrezionalità dell’Amministrazione, nell’ottica del principio di proporzionalità evidenziato più volte dalla giurisprudenza europea in materia, il legislatore ha sul punto precisato che il rifiuto dell’accesso deve considerarsi in ogni caso ingiustificato quando:
- è sufficiente il differimento dell’accesso per la tutela degli interessi di riservatezza che si intendono tutelare (art. 5-bis, comma 5);
- l’amministrazione può consentire l’accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell’oscuramento di alcuni dati (art. 5-bis, comma 4, secondo alinea).
L’ANAC non ha mancato, inoltre, di precisare che l’obbligo di motivazione per l’ente pubblico sussiste in tutti i casi in cui l’accesso sia negato – e non solo nei casi di esclusione automatica di cui al comma 3 dell’art. 5bis – nonché nei casi di accoglimento dell’istanza di accesso, in questo caso al fine della tutela degli interessi di eventuali terzi coinvolti.
Tanto il provvedimento di diniego dell’accesso che quello di accoglimento devono essere adeguatamente motivati.
5. Adempimenti richiesti alle amministrazioni
Secondo quanto previsto dal legislatore, a partire dallo scorso 23 dicembre 2016 le amministrazioni devono dare immediata applicazione all’istituto dell’accesso generalizzato, con la valutazione caso per caso delle richieste presentate.
Da ciò – rileva l’ANAC – discende l’opportunità̀ che le amministrazioni:
a) adottino nel più breve tempo possibile soluzioni organizzative al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso predisponendo una apposita disciplina interna sugli aspetti procedimentali;
c) istituiscano un registro delle richieste di accesso presentate (per le varie tipologie di accesso), “cd. registro degli accessi”, auspicabilmente da pubblicare sui propri siti.
Il registro, in particolare, deve contenere l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, “altri contenuti – accesso civico” del sito web istituzionale. La finalità del detto registro è duplice, secondo l’ANAC: da un lato, servirà a consentire la attività di monitoraggio sulle decisioni in tema di accesso adottate dalle singole amministrazioni, su cui l’ANAC intende vigilare; dall’altro, consentirà una semplificazione delle attività̀ rendendosi noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l’accesso.
L’attività dell’ANAC in materia non si arresta, dunque, con l’approvazione delle Linee Guida in oggetto. Queste ultime, peraltro, saranno oggetto di aggiornamento annuale, sempre d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali. In sede di aggiornamento – avvisa la stessa ANAC – si darà infatti conto della prassi medio tempore formatasi sulla base delle decisioni delle amministrazioni e/o delle decisioni rese su eventuali ricorsi amministrativi o giurisdizionali, selezionando le tecniche di bilanciamento e le scelte concretamente operate che risulteranno più̀ coerenti rispetto alle indicazioni formulate nelle predette Linee Guida.
[1] La definizione di ente a controllo pubblico è contenuta nel D.Lgs. 175/2016 c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
[2] Trattasi di associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
[3] Come precisato nelle Linee guida dell’ANAC, devono considerarsi quali «dati e ai documenti inerenti all’attività̀ di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea» – per i quali è possibile chiedere l’accesso generalizzato anche alle società a partecipazione pubblica – quelli qualificati come tali da una norma di legge, dagli atti costitutivi o dagli statuti delle società, l’esercizio di funzioni amministrative, la gestione di servizi pubblici nonché le attività che pur non costituendo diretta esplicazione della funzione o del servizio pubblico svolti sono ad esse strumentali.
[4] Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 175/2016 lett. n), le «società a partecipazione pubblica» sono le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico, intendendosi per «società a controllo pubblico» le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile.
[5] In tal modo l’ANAC si conforma a quanto espresso dal Consiglio di Stato con parere del 18.2.2016.
[6] L’ANAC richiama la definizione di segreto di stato è contenuta nell’art. 39 L. n. 124/2007, secondo cui “sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività̀ e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità̀ della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato”. Il potere di disporre il vincolo in oggetto è attribuito in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 39, comma 4) ed è soggetto a limite temporale pari a 15 anni dall’apposizione del segreto di o, in mancanza, dalla sua opposizione confermata.
[7] Per quanto riguarda i divieti di divulgazione, invece, rilevano ad esempio: dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità̀, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice della privacy; art. 7-bis, comma 6, D.Lgs. n. 33/2013); dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, comma 6, D.Lgs. n. 33/2013); dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (limite alla pubblicazione previsto dall’art. 26, comma 4, D.Lgs. n. 33/2013).
[8] Ai sensi della L. n. 241/90 il diritto di accesso va escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, da apposito regolamento governativo (ancora da adottare) e dalle pubbliche amministrazioni;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
Questo articolo è valutato
( votes)Questo articolo è stato scritto da...