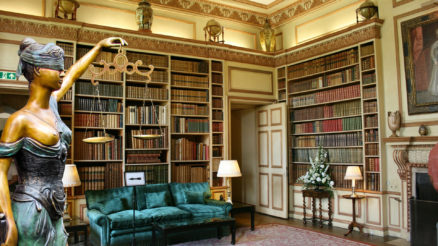Questo articolo è valutato
( vote)1. La moralità professionale delle imprese: evoluzione normativa
Come noto, il requisito della moralità professionale risulta presupposto indefettibile per consentire alle imprese di partecipare alle pubbliche gare d’appalto.
Facendo riferimento alla disciplina contenuta nel “vecchio” codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006), tale requisito consisteva, essenzialmente, nell’insussistenza in capo al soggetto concorrente di comportamenti penalmente rilevanti, accertati giudizialmente in via definitiva, riguardanti i reati enunciati dai citati articoli 38 del D.Lgs. 163/2006, ovvero riconducibili a fattispecie gravi in danno dello Stato o della Comunità concernenti situazioni, fatti e circostanze che risultano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante in relazione alla specifica obbligazione dedotta in contratto.
L’impresa poteva essere esclusa dalla procedura di affidamento una volta accertato che i provvedimenti di condanna, sentenza passata in giudicato, decreto penale divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., fossero adottati nei confronti del titolare, dei soci delle società in nome collettivo, dei soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altri tipi di società o di consorzio, e dei direttori tecnici.
A prescindere dai reati specificamente elencati nelle disposizioni menzionate, e cioè, partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio, che rappresentavano in ogni caso causa di esclusione dalla gara o per i quali vigeva una preclusione assoluta alla conclusione del contratto, le condanne comminate agli esponenti dell’impresa dovevano: a) possedere il requisito della gravità; b) incidere sulla moralità professionale; c) essere stati commessi in danno dello Stato o della Comunità.
L’art. 80 del nuovo Codice degli appalti, sulla scorta di quanto previsto dalla direttiva UE 24/2014, ha quasi totalmente riprodotto il contenuto dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, attribuendo agli operatori economici la possibilità di ravvedersi mediante l’adozione di misure di cosiddetto self-cleaning, prevedendo inoltre nuove cause di esclusione ed ampliando il novero dei destinatari della stessa.
Anche il nuovo codice dei contratti prevede che costituisca motivo di esclusione dalla procedura la condanna irrogata con sentenza definitiva, decreto penale divenuto irrevocabile sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.
Vi è tuttavia una elencazione più ampia e specifica dei reati considerati incidenti sulla moralità professionale delle imprese, che sono i seguenti:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. n. 309/1990, dall’art.291-quater del D.P.R. n. 43/1973 e dall’art. 260 del d.lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del d.lgs. n. 109/2007;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. n. 24/2014;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
L’art. 80, co. 3, del nuovo codice, dispone poi che l’esclusione dalla gara vada disposta quando la sentenza di condanna (o il decreto ovvero la misura interdittiva) sia stata emessa nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso, l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Proprio a proposito del self-cleaning, il comma 7 dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 dispone che l’operatore economico, anche in presenza di una delle cause di esclusione previste dall’articolo medesimo, potrà dimostrare il permanere della propria affidabilità provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. La direttiva 24/2014 precisa che spetterà, in ogni caso, all’amministrazione aggiudicatrice il compito di valutare se le misure adottate dal concorrente siano state realmente sufficienti, tenuto conto della gravità e delle particolari circostanze del reato o dell’illecito commesso. Nel caso in cui le misure siano ritenute insufficienti, infine, è previsto l’obbligo per l’amministrazione di motivare esplicitamente la decisione di esclusione che verrà assunta nei confronti dell’operatore economico.
Sia il vecchio che il nuovo codice contengono una norma di “chiusura” che, prescindendo dall’emissione di sentenze passate in giudicato nei confronti dei rappresentanti dell’impresa, mira a tutelare l’affidabilità di quest’ultima. L’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (vecchio codice), in particolare, prevedeva, al comma 1 lett. f), l’esclusione dell’impresa che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante.
Nelle pubbliche gare d’appalto, l’operatore economico va escluso dalla gara quando la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che quest’ultimo si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità
Ora, l’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice), al comma 5 lett. c), con disposizione ben più articolata, dispone che l’operatore economico va escluso dalla gara quando la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che quest’ultimo si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
2. Le linee guida dell’ANAC
Proprio in ordine all’interpretazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, le ormai note linee guida dell’Anac n. 6/2017 (approvate con la deliberazione n.1008/2017) hanno stabilito che anche la condanna non definitiva può rilevare ai fini del grave illecito professionale e, conseguenzialmente, determinare l’esclusione dall’appalto.
Nelle dette linee guida, il concetto di grave illecito professionale, accertato con provvedimento esecutivo a prescindere dalla sua natura civile, penale o amministrativa, ricomprende ogni condotta che rende dubbia la moralità professionale del concorrente o la sua affidabilità.
Novità, rispetto alla bozza posta originariamente in consultazione, è la rilevanza della condanna non definitiva per alcuni reati, che può configurarsi quale illecito professionale grave tale da rendere dubbia l’integrità dell’operatore economico.
Secondo le linee guida dell’ANAC, anche la condanna non definitiva può rilevare ai fini del grave illecito professionale e, conseguenzialmente, determinare l’esclusione dall’appalto.
In applicazione di questo principio, è stata ritenuta rilevante la condanna non definitiva per i reati di abusivo esercizio di una professione, reati fallimentari, tributari, societari, urbanistici e reati previsti dal D.lgs. 231/2001, salvo che la stessa configuri altra causa ostativa atta a determinare l’automatica esclusione dalla procedure di affidamento.
Altrettanto rilevante è la condanna non definitiva per i reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale da verificarsi con acquisizione del certificato dei carichi pendenti, fermo restando che quella definitiva per tali reati costituisce motivo di esclusione in base a quanto previsto dall’articolo 80, comma 1, lettera b) del codice.
La previsione di accordi con altri operatori economici, diretti a falsare la concorrenza, assume rilevanza soltanto se tali accordi risultino oggettivamente idonei a incidere sulla regolarità della procedura, nonché debitamente documentati. La rilevanza ostativa dei provvedimenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell’ANAC stata collegata alla loro esecutività, per garantire tempestività e semplificazione all’accertamento. Sotto quest’ultimo profilo, le applicazioni di penali costituiscono presupposto significativo se, singolarmente o cumulativamente, sono superiori all’1% dell’importo del contratto.
Particolarmente significativo, al riguardo, è l’onere dichiarativo gravante sulle imprese partecipanti alle gare sulle eventuali cause ostative alla partecipazione stessa. E’ stato infatti espressamente specificato dall’ANAC che la dichiarazione sostitutiva resa dall’operatore economico mediante ilmodello “DGUE” debba comprendere tutti i provvedimenti astrattamente idonei a costituire illecitoprofessionale, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico, non essendo configurabile,in capo all’impresa, alcun filtro valutativo, per permettere alla stazione appaltante di espletare conpiena cognizione di causa le valutazioni di competenza.La fattispecie ostativa si configura con l’accertamento del fatto e non con l’annotazione nelcasellario informatico, che non ha natura costitutiva ma di pubblicità notizia.
La dichiarazione sostitutiva resa in sede di gara dall’operatore economico mediante il modello “DGUE” deve contenere tutti i provvedimenti astrattamente idonei a costituire illecito professionale, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico, per consentire stazione appaltante di espletare con piena cognizione di causa le valutazioni di competenza
L’ANAC ha inoltre precisato che la durata dell’interdizione alla partecipazione alle procedure di appalto è stabilita dall’articolo 80, comma 10 del codice e la data dell’accertamento del fatto, ove non sia intervenuta una sentenza penale di condanna, è individuata dalle linee guida.
Infine, per ciò che concerne le misure di self cleaning, l’apprezzamento della stazione appaltante èeffettuato in contraddittorio con l’operatore economico, ma le stesse sono valutate con massimorigore nell’ipotesi di violazione del principio di leale collaborazione con l’Amministrazione.
3. Il caso affrontato dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 20 dicembre 2017, nella causa C-178/16)
A proposito delle questioni affrontate dall’ANAC nelle linee guida, ed in particolare dell’incidenza della condanna non definitiva sulla moralità professionale delle imprese, la Corte di Giustizia UE, con pronuncia destinata ad avere notevole riverbero nelle procedure d’appalto degli stati membri, ha affermato che anche le sentenze di condanna non passate in giudicato debbono essere autodichiarate, pur se riferite ad un soggetto cessato dalla carica. A confermare questa regola, è la Corte di Giustizia, nella sentenza depositata il 20 dicembre 2017, nella causa C-178/16, che chiude ancora una volta una vicenda nata da una domanda di pronuncia pregiudiziale italiana.
Secondo la Corte di Giustizia UE, anche le sentenze di condanna non passate in giudicato debbono essere autodichiarate, pur se riferite ad un soggetto cessato dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara.
La vicenda ci riguarda, per così dire, da vicino, considerato che la questione era stata posta dal Consiglio di Stato, Sez. VI (con ordinanza 21 marzo 2016 n. 1160), e riguardava il caso di un’impresa esclusa da una gara per aver dichiarato che il proprio presidente del consiglio di amministrazione, nonché amministratore delegato e legale rappresentante, cessato dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, non aveva riportato alcuna sentenza di condanna definitiva. Tuttavia, nel corso della procedura, la stazione appaltante veniva a conoscenza del fatto che, proprio dieci giorni prima della data della presentazione dell’offerta da parte dell’impresa, tale soggetto aveva invece patteggiato una condanna ad un anno e dieci mesi di reclusione per aver promosso un sistema di fatture false. Pertanto, venivano richiesti chiarimenti al concorrente sulla mancata dichiarazione del precedente penale.
A tal riguardo, l’impresa sosteneva che la sentenza era passata in giudicato solamente a distanza di tre mesi dalla partecipazione alla gara, e quindi non fosse definitiva al momento della presentazione della autodichiarazione; e che, comunque, dopo aver appreso la notizia, l’impresa stessa si fosse dissociata dalla condotta dell’amministratore, rispetto al quale era stata disposta la rimozione da tutte le cariche sociali, il riscatto delle azioni detenute e l’avvio di un’azione di responsabilità, adottando quindi le necessarie cautele di self cleaning.
La Stazione appaltante, dunque, ha chiesto un parere all’ANAC in merito alla legittimità di un’eventuale esclusione dell’impresa in questione. L’ANAC ha sostanzialmente risposto che, sebbene, in mancanza di una sentenza irrevocabile, le dichiarazioni dell’impresa non potessero essere qualificate come «falsa dichiarazione», tuttavia la mancata tempestiva comunicazione dello sviluppo delle vicende penalmente rilevanti riguardanti uno dei soggetti menzionati all’articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163/2006 (normativa applicabile ratione temporis alla fattispecie) poteva costituire una violazione del dovere di leale collaborazione con la stazione appaltante, impedendo così l’effettiva e completa dissociazione rispetto al soggetto interessato. Di conseguenza, adottava un provvedimento di esclusione in base alla duplice motivazione dell’insufficiente e tardiva dimostrazione della dissociazione dalla condotta penalmente rilevante posta in essere dal soggetto cessato dalla carica, e della mancata dichiarazione della sentenza che era stata in ogni caso pronunciata in un momento antecedente alla gara.
Il Consiglio di Stato quale ha deciso di rivolgersi alla Corte di Giustizia UE per chiedere se sia legittimo e conforme ai principi comunitari escludere un’impresa dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto con la motivazione che, omettendo di dichiarare una condanna non ancora definitiva di un amministratore cessato dalla carica da meno di un anno, l’impresa non si sarebbe effettivamente e completamente dissociata dalla condotta del suddetto amministratore.
Tale provvedimento veniva impugnato dinanzi al TAR e, dopo il rigetto del ricorso in primo grado, è stato promosso appello dinanzi al Consiglio di Stato, il quale ha deciso di rimettere la questione alla Corte di Giustizia UE per chiedere se fosse compatibile con la disciplina comunitaria l’articolo 38, comma 1, lettera c), del previgente Codice – identico nei contenuti all’attuale articolo 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 – e se la direttiva 2004/18, nonché i principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che consente all’amministrazione aggiudicatrice di tener conto, secondo le condizioni da essa stabilite, di una condanna penale a carico dell’amministratore di un’impresa offerente, per un reato che incide sulla moralità professionale di tale impresa, qualora il suddetto amministratore abbia cessato di esercitare le sue funzioni nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara d’appalto pubblico, e di escludere tale impresa dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione con la motivazione che, omettendo di dichiarare detta condanna non ancora definitiva, l’impresa non si sarebbe effettivamente e completamente dissociata dalla condotta del suddetto amministratore.
4. I motivi posti alla base della decisione della Corte
Con una pronuncia che, sostanzialmente, si pone in linea con quanto ravvisato dall’ANAC nelle linee guida di cui si è fatto cenno, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto che sia del tutto compatibile con la disciplina comunitaria una norma nazionale che consenta ad una stazione appaltante di tener conto di condanne penali per reati incidenti sulla moralità professionale a carico dell’amministratore di un’impresa, anche se tali provvedimenti non siano ancora passati in giudicato e nonostante che i soggetti condannati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. Di conseguenza, la norma è compatibile anche nella parte in cui consente all’amministrazione di escludere l’impresa, qualora non si sia effettivamente e completamente dissociata dalla condotta dell’amministratore.
Secondo la Corte di Giustizia UE è pienamente compatibile con la disciplina comunitaria una norma nazionale che consenta ad una stazione appaltante di tener conto di condanne penali per reati incidenti sulla moralità professionale a carico dell’amministratore di un’impresa, anche se tali provvedimenti non siano ancora passati in giudicato e nonostante che i soggetti condannati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara
La Corte di Giustizia UE muove innanzitutto da una premessa di carattere generale secondo cui, rispetto ai motivi facoltativi di esclusione elencati nell’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/Ce, spetta agli Stati membri precisarne le condizioni di applicazione.
Posto che, infatti, le imprese agiscono tramite i propri rappresentanti, un comportamento di tali soggetti che sia contrario alla moralità professionale può costituire un elemento rilevante ai fini della valutazione della stessa moralità professionale dell’impresa; ed è quindi possibile, per gli Stati membri, valutare in tal senso le condotte di un amministratore cessato dalla carica, e ritenere rilevante – ai fini della moralità – un reato, come quello commesso nel caso di specie, che consisteva nella emissione di fatture false; così come, è possibile consentire all’impresa di presentare alla stazione appaltante tutte le prove necessarie a dimostrare la propria dissociazione dalla condotta del cessato.
Le circostanze esaminate potrebbero dunque integrare, ad avviso della Corte, errore grave ai sensi dell’art. 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d), della direttiva 2004/18/Ce, il quale consente appunto di escludere un offerente «che, nell’esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’amministrazione aggiudicatrice». Anzi, come specifica la Corte medesima, tale disposizione si presta proprio ad essere applicata in una situazione in cui la sentenza di condanna per un reato incidente sulla moralità professionale non sia ancora definitiva, differenziandosi dall’ipotesi normativa della esclusione determinata da sentenze di condanne passate in giudicato per il semplice fatto che l’amministrazione aggiudicatrice può invece provare, con qualsiasi mezzo di prova, la sussistenza di un errore grave.
Oltretutto, particolare risalto è stato dato dalla Corte anche all’aspetto temporale della vicenda, ed a come il decorso del tempo possa incidere sulla rilevanza del comportamento illecito dell’amministratore di un’impresa, sì da essere ritenuto idoneo a determinare l’esclusione del concorrente. Secondo la Corte, tuttavia, la disciplina italiana sembra essere rispondente al principio di proporzionalità, prendendo in considerazione l’arco temporale del solo anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
Addirittura, nel caso di specie, la Corte ha enfatizzato la circostanza per la quale l’operatore economico coinvolto non aveva informato la stazione appaltante della condotta penalmente rilevante dell’ex amministratore, potendo tale comportamento costituire un elemento valutativo che consente di escludere un concorrente dalla partecipazione ad una gara d’appalto, essendo inquadrabile nell’ambito della diversa fattispecie prevista dall’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera g), della direttiva 2004/18/Ce, il quale contempla il caso dell’estromissione di un operatore economico che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni.
5. L’impatto della sentenza in commento sull’attuale disciplina codicistica
Ovviamente, trattandosi di vicenda sorta sotto la vigenza del d.lgs. n. 163/2006, viene spontaneo domandarsi quale impatto tale pronuncia potrà avere sull’attuale disciplina contenuta nel d.lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti), e se possa essere ad essa riferibile.
La transizione dalla vecchia alla nuova disciplina (art. 80 d.lgs. 50/2016) sui requisiti di ordine generale ha mantenuto quasi totalmente la struttura originaria dell’articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006
Come abbiamo visto sopra, la transizione dalla vecchia alla nuova disciplina sui requisiti di ordine generale ha mantenuto quasi totalmente la struttura originaria dell’articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006. Esattamente come nel vecchio codice, infatti, anche l’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 ha deciso per il recepimento dei motivi facoltativi di esclusione di cui all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/Ue, nell’ambito dei quali sono state inserite nuovamente le ipotesi del grave illecito professionale (che ha preso il posto dell’errore grave) e delle false dichiarazioni, ed ha confermato – con i commi 1 e 3 – la regola dell’esclusione dalla gara per sussistenza di sentenze di condanna definitive, anche se riguardanti i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.
In realtà, la differenza rispetto alla vecchia normativa risiede nell’ipotesi delle condanne passate in giudicato.
Nell’ambito di tale fattispecie, infatti, la precedente direttiva del 2004 distingueva tra casi obbligatori e facoltativi di esclusione (entrambi trasposti nell’articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006): i primi, che dovevano essere obbligatoriamente recepiti dagli Stati Ue, comportavano l’esclusione del concorrente condannato per determinate tipologie di reato (partecipazione ad organizzazioni criminali, corruzione, frode e riciclaggio); i secondi, invece, potevano essere recepiti o no dagli Stati membri, e riguardavano i diversi casi di condanne passate in giudicato per reati incidenti sulla moralità professionale.
Non troviamo tuttavia questa distinzione nelle direttive del 2014, le quali hanno invece posto in luce soltanto le sentenze di condanna definitiva per reati di partecipazione ad organizzazioni criminali, corruzione, frode e riciclaggio, cui sono stati affiancati anche quelli di terrorismo e lavoro minorile, così abbandonando la categoria dei reati incidenti sulla moralità professionale; ad ogni modo, in fase di recepimento, il legislatore italiano ha comunque introdotto, in via ulteriore, all’interno del comma 1 dell’articolo 80, il caso dei provvedimenti di condanna passati in giudicato per delitti che comportano l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
Pertanto, alla luce di questa nuova e specifica declinazione dei reati rilevanti, ci si domanda se possano considerarsi attuali le considerazioni cui è giunta la Corte, soprattutto con riferimento alla previsione dell’obbligo dichiarativo delle condanne anche a carico dei soggetti cessati dalla carica; e ciò, anche in funzione del fatto che l’articolo 57, paragrafo 1, comma 2, della direttiva 2014/24/Ue circoscrive in realtà tale obbligo ai soli membri del cda, ai membri di direzione o di vigilanza dell’impresa o ai soggetti con poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.
D’altro canto, la sentenza in commento risulta del tutto coerente le linee-guida Anac in merito alla rilevanza delle sentenza di condanna anche se non passate in giudicato. Come oramai noto, infatti, l’ANAC è stata chiamata all’adozione di tale provvedimento dal comma 13 dell’articolo 80 del Codice, il quale ha previsto che l’Anac potesse precisare, con apposite linee guida, i mezzi di prova adeguati per la dimostrazione della circostanza di esclusione del grave illecito professionale indicato dalla lettera c) del comma 5 dello stesso articolo 80, e le carenze significative nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto.
Nell’ambito di tale provvedimento, è stato infatti precisato che rilevano – in termini di grave illecito professionale – anche le condanne non definitive per determinate fattispecie di reato che l’Autorità elenca a titolo meramente esemplificativo, includendovi l’abusivo esercizio di una professione, i reati fallimentari (bancarotta semplice e fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario fallimentare, nonché ricorso abusivo al credito), i reati tributari, i reati societari, i delitti contro l’industria e il commercio, i reati urbanistici e i reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001. Ma, unitamente a queste fattispecie, l’Anac considera rilevanti anche quelle per i reati di cui agli articoli 353, 353- bis, 354, 355 e 356 del codice penale, cioè per turbata libertà degli incanti o del procedimento di scelta del contraente, astensione dagli incanti, inadempimento di contratti di pubbliche forniture e frode nelle pubbliche forniture.
La stessa Autorità ha peraltro specificato che anche in tali ipotesi l’accertamento di tali condanne non definitive deve essere condotto dalla stazione appaltante sugli stessi soggetti a carico dei quali vengono effettuate le verifiche dei provvedimenti passati in giudicato, indicati dal comma 3 dell’articolo 80, che include appunto anche i soggetti cessati dalla carica: ragion per cui, le linee-guida prevedono che debbono essere acquisiti i relativi certificati dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza della persona sottoposta a controllo.
L’accertamento di tali condanne non definitive deve essere condotto dalla stazione appaltante sugli stessi soggetti a carico dei quali vengono effettuate le verifiche dei provvedimenti passati in giudicato, indicati dal comma 3 dell’articolo 80 d.lgs. 50/2016
Allo stesso modo, le indicazioni dell’Anac appaiono in linea con le previsioni giurisprudenziali della Corte di giustizia UE anche rispetto all’obbligo dichiarativo delle sentenze di condanna non passate in giudicato al momento di presentazione dell’offerta. In tal senso, infatti, l’ANAC ha specificato che la sussistenza di gravi illeciti professionali deve essere autodichiarata in sede di partecipazione alla gara, spettando esclusivamente alla stazione appaltante il vaglio in ordine alla rilevanza di tali comportamenti; di conseguenza, l’omissione di tale dichiarazione comporta l’applicazione dell’articolo 80, comma 1, lettera fbis), del Codice, il quale prevede appunto il caso dell’estromissione dalla gara per aver reso un falso, trattandosi appunto di falsa attestazione della insussistenza di tali situazioni astrattamente idonee a configurare una causa di esclusione.
In definitiva, dunque, pur con tutte le riserve del caso, legate ad una applicazione ancora incerta del nuovo codice dei contratti, la sentenza in commento della Corte di giustizia UE pare perfettamente compatibile con le linee guida dell’ANAC e con la possibilità di prendere in considerazione – in termini di grave illecito professionale – anche le condanne non passate in giudicato riferite ai cessati dalla carica.